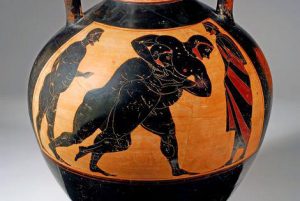“Lo spirito del fanciullo è debole, è così facile sottometterlo col terrore… Lo rendono timido, ed allora gli parlano dei tormenti dell’inferno; innanzi ai suoi occhi fanno balenare le sofferenze dell’anima dannata, la vendetta di un dio implacabile. Poco dopo gli parleranno degli orrori della Rivoluzione, e sfrutteranno un eccesso dei rivoluzionari per fare del fanciullo un “amico dell’ordine”. Il religioso l’abituerà all’idea della legge per farlo meglio obbedire a ciò che chiamerà la legge divina, e l’avvocato gli parlerà della legge divina per farlo meglio obbedire alla legge del codice.
Così il pensiero della generazione vegnente prenderà questa piega religiosa, questa piega autoritaria e servile nel tempo stesso – autorità e servilismo van sempre di conserva -, quest’abitudine di sottomissione che noi dobbiamo riconoscere purtroppo nei nostri contemporanei.”
Ecco il cuore del problema morale, messo nero su bianco da Kropotkin nel 1890 nell’opuscolo intitolato La Morale Anarchica: la pedagogia. Proprio intorno a quel periodo, se guardiamo in Italia, erano numerosi i pedagogisti che affermavano con forza la centralità dell’insegnamento religioso nella formazione morale del fanciullo (Rosmini, Capponi, Gioberti e soprattutto gli asili di Aporti, precocissime macchine di indottrinamento). Là dove non arrivava la longa manus dei ministri di dio, vi era quella borghese: la scuola doveva infatti formare i giovani per l’entrata nel mercato del lavoro, il che – tradotto – significava fornirgli un’istruzione di base (a volte mascherata da filantropia, come nel caso delle scuole di mutuo insegnamento) per poi impiegarli come forza-lavoro nelle fabbriche. È nelle scuole e nei processi educativi in generale che si genera la morale autoritaria e servilista; come osserva giustamente Kropotkin, le due cose vanno a braccetto. Ogni membro della classe media, anche il piccolo borghesuccio di paese, sa comportarsi da padrone, imitando il modello che ha assorbito da fanciullo (il Padre onnipotente che punisce gli uomini che non seguono la sua parola; il Capitalista sulla vetta della piramide sociale); ma sa comportarsi anche da suddito servile e fidato, senza il quale non vi sarebbero padroni, sempre secondo il modello che gli è stato insegnato da piccolo (la “pecora smarrita” guidata dal prete, il pastore di “anime”; l’ingranaggio del sistema capitalista).
La Morale Anarchica di Kropotkin è figlia del suo tempo, imbevuta di ideali positivisti e di elementi evoluzionistici: tutta la filosofia della seconda metà dell’Ottocento risente pesantemente dell’influenza de L’Origine della Specie di Darwin. Di qui il rifiuto radicale di ogni metafisica e di ogni morale fondata su di essa, giungendo ad inscrivere il bene e il male nel mondo animale: qui questi concetti considerati metafisici si riducono a ciò che è utile per la specie e a ciò che le reca danno. Così, scrive Kropotkin, è buona la formica che condivide con quelle affamate il cibo trovato, com’è buono l’uomo che non accentra avidamente le ricchezze per sé ma le condivide con chi non è abbiente. Entrambi operano per il bene della specie. Questo bene viene definito così da Kropotkin:
“Tratta gli altri come a te piacerebbe di esser trattato da loro in circostanze analoghe.” (cap. VI)
Questa definizione mette in grande imbarazzo l’impianto morale che Kropotkin cerca di sostenere. Esso può essere abbattuto con tre colpi di “filosofia del martello” (l’espressione è nitzscheiana).
I colpo: il prete rientra dalla finestra
Innanzitutto, ecco che il prete, messo alla porta all’inizio dell’opera, rientra dalla finestra. Leggiamo proprio nel vangelo di Matteo:
“Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro; perché questa è la legge dei profeti.” Matteo 7, 12
Come conciliare l’avversione di Kropotkin per i preti che avvelenano la mente del fanciullo con l’etica cristiana e la sua idea di bene che è esattamente la stessa dei vangeli? Bisogna correggere il tiro e dire che, dal punto di vista anarchico, il prete insegna la via corretta dell’agire etico, ma ne rappresenta un cattivo esemplare. Dunque, va spostato il fondamento: dalla metafisica – dio – alla biologia evoluzionista – specie -, in un procedimento che ricorda da vicino il rovesciamento di Feuerbach; ma il nucleo etico non cambia. Il fanciullo è moralmente ben formato dal prete; ora non gli resta che sbarazzarsi di dio (di cui Nietzsche aveva già annunciato la morte qualche anno prima).
II colpo: non capire la Critica della Ragion Pratica
Nel capitolo I, Kropotkin scrive:
“Perché dovrei essere morale? […] dovrei esserlo perché Kant mi parla di un imperativo categorico, di un ordine misterioso che proviene dal fondo del mio io stesso e che mi ordina di essere morale. Ma perché questo imperativo categorico dovrebbe avere maggiori diritti sui miei atti che quell’altro imperativo il quale, di tanto in tanto, mi darà l’ordine di ubriacarmi?
Una parola, nulla più di una parola, non diversamente da quella della Provvidenza o del Destino, inventata per ricoprire la nostra ignoranza!”
È evidente che Kropotkin non ha capito Kant. L’imperativo categorico, che viene definito “ordine misterioso”, è ciò che si contrappone all’agire naturale degli istinti. Se si ammette che l’uomo è capace di arbitrio, ci sono due livelli, ben esemplificati dal mito della biga alata di Platone: da una parte il regno degli istinti (l’agire naturale, non etico), dall’altro il regno dei fini, il mondo ideale dove ognuno obbedisce incondizionatamente alla legge morale. L’uomo si trova nel mezzo: può scegliere – in quanto libero – di aderire ora all’uno, ora all’altro. “L’altro imperativo” che ordina a Kropotkin di ubriacarsi si chiama “massima”, ed è un principio pratico soggettivo che non ha nulla a che fare con la legge morale. Se invece cerchiamo la definizione di legge morale nella Critica della Ragion Pratica, eccola:
“Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere come principio di una legislazione universale.”
In Fondazione della Metafisica dei Costumi, troviamo altre due versioni dello stesso principio:
“Agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo.”
“Agisci in modo che la volontà, in base alla massima, possa considerare contemporaneamente se stessa come universalmente legislatrice.”
Si tratta, come si vede, di versioni più complesse della stessa definizione data da Kropotkin, che, a quanto pare, era kantiano a sua insaputa. Se l’agire etico, come sostiene, è fare agli altri ciò che si vuole sia fatto a noi, allora significa, esattamente come scrive Kant, che le nostre azioni, per essere etiche, devono considerarsi universali, valide per gli altri e per noi.
Kropotkin, nel capitolo X, si chiede se la sua etica sia egoistica o altruistica, concludendo che non è né l’una né l’altra: è una distinzione fittizia, perché agire altruisticamente per la specie è anche agire egoisticamente per se stessi. La stessa cosa è sostenuta da Kant, in termini diversi, nella Critica della Ragion Pratica. Ma anche leggendo soltanto la terza definizione di legge morale, si coglie immediatamente come il soggetto che agisce eticamente è allo stesso tempo legislatore (la sua volontà è diretta secondo la massima, cioè secondo un principio pratico soggettivo, fondato sull'”io”) e soggetto alla legislazione universale (la sua volontà ubbidisce all’imperativo categorico, cioè coincide con l’oggettività formale e impersonale della legge etica). Anche in Kant, come in Kropotkin, soggettivo e oggettivo, egoismo e altruismo, coincidono nello stesso punto: l’agire etico.
III colpo: Nietzsche e Darwin, il colpo di grazia
Cosa resta allora della morale anarchica, oltre il messaggio evangelico e kantiano? L’agire morale è l’utile della specie, il male ciò che gli reca danno, scrive Kropotkin sotto l’influenza darwinista. Un’influenza però oltremodo superficiale, come ci spiega Nietzsche – che Darwin l’aveva capito molto più a fondo – ne La Gaia Scienza. Se dunque vogliamo parlare di cosa è bene per la specie (e non di cosa è bene in sé), troviamo che tutto ciò che gli uomini sono portati a fare per natura è funzionale alla conservazione della specie. Mentre Kropotkin si aggira nella superficie delle cose, liquidando Kant con una battuta, i preti “in sottana” con un’altra, Nietzsche, questo genio della decostruzione, va al fondo delle cose: non esistono fenomeni morali, solo interpretazioni morali di fenomeni. Kropotkin fa parte della pantomima “stilistica” moraleggiante, con cui si abbelliscono le azioni umane, tanto quanto Kant o i ministri di dio. Mentre l’anarchico che aderisce “un momento sì e l’altro no” all’evoluzionismo si rammarica per la presenza di assassini nella società (ad esempio di Jack lo squartatore), Nietzsche ci spiega che essi fanno il bene della specie tanto quanto i moralisti come Kropotkin: quelli, infatti, contribuiscono alla causa della razza umana conservando e tramandando istinti senza i quali essa non sarebbe potuta – e non potrebbe – sopravvivere. In sostanza, se l’agire morale è l’utile della specie, allora tutto (compreso ciò che comunemente viene ritenuto male) è morale. Questo è il paradosso a cui conduce ogni etica che abbia la pretesa di fondarsi sulla conservazione della specie, come evidenziato magistralmente da Nietzsche ne La Gaia Scienza; questo è il motivo per cui Kant ritiene che non si possa parlare di morale in riferimento all’agire naturale; ed è questo il motivo decisivo per cui La Morale Anarchica di Kropotkin non è niente di più che un documento storico ininfluente dal punto di vista della filosofia morale.